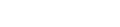ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
02/23/2024 | Press release | Distributed by Public on 02/23/2024 10:33
UE: in campo sui medicinali critici
La maggior parte dei Paesi dell'Unione Europea ha registrato negli ultimi anni carenze di alcuni medicinali alla base della salute e del benessere dei cittadini. Un'emergenza che ha richiesto all'UE di fare tesoro dell'esperienza maturata durante la pandemia e adottare una nuova governance comune per rendere resilienti le complesse catene di approvvigionamento indebolite ai tempi della "grande frammentazione".
Medicinali: catene lunghe e fragili
Nonostante l'industria farmaceutica europea sia tra le principali al mondo, la carenza di alcuni medicinali desta preoccupazione nell'UE da diversi anni. Il problema delle carenze si è aggravato durante la pandemia di Covid-19 quando abbiamo assistito ad un aumento improvviso della domanda di alcuni medicinali - per esempio, anestetici, antibiotici, miorilassanti - e ad un'offerta bloccata dalla chiusura delle attività dei fornitori, da problemi logistici e da misure protezionistiche nazionali come lo stoccaggio e i divieti all'esportazione.
Se è vero che l'industria europea eccelle sul fronte della ricerca e sviluppo e nella produzione di medicinali più complessi, la dipendenza da Paesi terzi per molti medicinali è andata crescendo perché, coerentemente con il funzionamento della globalizzazione, la produzione si è concentrata per la specializzazione dei singoli Paesi. Quasi il 70 per cento dei medicinali dispensati in Europa è costituito da medicinali generici prodotti principalmente all'estero con catene di approvvigionamento geograficamente estese, spesso non sufficientemente diversificate. Per esempio, l'80 per cento dei principi attivi contenuti nei medicinali e il 40 per cento dei medicinali venduti in Europa provengono da Cina e India; questi due Paesi producono il 60 per cento del paracetamolo mondiale, il 90 per cento della penicillina e il 50 per cento dell'ibuprofene.
L'autonomia strategica aperta: l'UE diventa proattiva
Le recenti interruzioni e i rallentamenti delle produzioni e dei trasporti hanno fatto tramontare il mito della globalizzazione di un mondo appiattito al ritmo veloce del just-in-time. Le catene di approvvigionamento si sono rivelate fragili per effetto dei crescenti attriti geopolitici che ci portano a parlare di grande frammentazione dell'ordine mondiale in cui le dipendenze economiche possono essere usate come arma di ritorsione.
In questo contesto, l'UE ha sviluppato il concetto di"autonomia strategica aperta". Se l'obiettivo dell'autonomia sui prodotti essenziali - sostenendo gli investimenti sul territorio europeo e il re-shoring delle catene di approvvigionamento - può essere riferito ad un ipotetico lungo periodo di keynesiana memoria, nel breve periodo non si può prescindere dalle importazioni. L'UE deve quindi mantenere l'apertura ai mercati internazionali, ma adesso, essere proattiva per garantire la resilienza delle catene di approvvigionamento dei medicinali, ovvero la capacità di resistere a shock quali rallentamenti o interruzioni, tramite maggiori scorte, l'accorciamento delle catene e la diversificazione dei fornitori.
La pandemia ha dimostrato che spesso le autorità pubbliche non hanno accesso a informazioni complete sulla struttura delle catene di fabbricazione e di approvvigionamento. Il Consiglio Europeo del 2 ottobre 2020 ha quindi invitato la Commissione a individuare le dipendenze strategiche, in particolare nell'industria della salute; per rispondere a tale invito, l'UE ha dovuto innanzitutto definire una nuova governance in questo settore.
Una nuova governance UE per la fornitura di farmaci
Durante il Covid-19, l'UE ha lavorato per trovare soluzioni comuni ad un'emergenza comune in un contesto in cui l'organizzazione dei sistemi sanitari, e in particolare la supervisione dell'approvvigionamento di medicinali, è una competenza nazionale di ciascuno Stato membro. L'UE ha voluto fare tesoro delle nuove soluzioni adottate durante la pandemia come, per esempio, nel caso delle nuove soluzioni dell'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale, ventilatori polmonari e vaccini in cui vi è stata una cooperazione efficace tra le autorità pubbliche e di regolamentazione nazionali, l'industria e le organizzazioni della società civile. L'11 novembre 2020 la Commissione Europea ha adottato quindi l'iniziativa "Unione Europea della salute" per dotare l'UE di un potere di intervento quando le emergenze interessano più Paesi e quando l'azione comune risulta più efficace ed efficiente rispetto a quella a livello nazionale. La nuova iniziativa interviene sia a livello UE, sia a livello di coordinamento tra Paesi.
Per il livello UE, la Commissione ha consolidato il suo ruolo acquisito durante la pandemia creando nel settembre 2021 l'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA). HERA dovrà gestire le gravi minacce a carattere transfrontaliero, tra gli altri, affrontando le vulnerabilità e le dipendenze strategiche dell'UE per quanto riguarda lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione, la costituzione di scorte e la distribuzione di attrezzature mediche, strumenti diagnostici e medicinali. Nella nuova governance viene potenziato il ruolo dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) che, dal marzo 2022, dovrà anche "preparare, prevenire, coordinare e gestire l'impatto di emergenze di sanità pubblica sui medicinali e sui dispositivi medici e di eventi gravi sui medicinali e sui dispositivi medici a livello dell'Unione", e "monitorare, prevenire le carenze di medicinali e di dispositivi medici e riferire in merito a tali carenze". All'interno dell'EMA si crea, quindi, un Gruppo direttivo per le carenze dei medicinali (MSSG) composto da rappresentanti di EMA, Commissione Europea e autorità nazionali (l'AIFA per l'Italia) per monitorare la domanda e l'offerta di medicinali con un nuovo sistema europeo armonizzato per registrare carenze, divieti di esportazione o di commercio parallelo, ritiri da parte delle imprese. In caso di carenze critiche, all'interno dell'UE è stato istituzionalizzato nell'ottobre 2023 il Meccanismo volontario di solidarietà tramite il quale se uno Stato membro ha necessità di un dato medicinale lo segnala agli altri Stati membri, i quali possono rendere disponibili eventuali scorte. Il sistema di monitoraggio verrà facilitato da una nuova piattaforma informatica - European shortages monitoring platform (ESMP) - che dovrà essere operativa da Febbraio 2025.
Medicinali critici: l'alleanza per il dialogo pubblico-privato
Attenzione particolare meritano i medicinali critici, ovvero quelli indispensabili ai fini della continuità delle cure e al mantenimento di un livello elevato di tutela della salute pubblica (come nel caso dei vaccini) e la cui indisponibilità espone i pazienti a un danno grave, o a un rischio di danno grave, per assenza di alternative adeguate. Lo scorso 12 dicembre, l'MSSG ha individuato 268 principi attivi la cui offerta è da monitorare costantemente e, in caso di carenze, coadiuvato da un gruppo di lavoro (SPOC Working Party), dovrà coordinare le attività per risolvere i problemi connessi all'approvvigionamento.
Sempre nell'ottica di rafforzare la governance in questo settore, all'inizio del 2024 è stata costituita l'alleanza per i medicinali critici - Critical Medicines Alliance - così come indicato dalla Commissione Europea nella comunicazione "Risposta alle carenze di medicinali nell'Unione Europea" del 24 ottobre 2023, la cui composizione sarà definita entro fine aprile 2024. Questa "alleanza", oltre alla Commissione Europea, alle agenzie dell'UE e alle autorità nazionali citate in precedenza, includerà altri stakeholder quali aziende, ONG e altri rappresentanti della società civile. Anche in questo settore, l'UE propone un modello adottato nel 2017 per le batterie elettriche (European Battery Alliance) e nel 2020 per le materie prime (European Raw Materials Alliance).
L'obiettivo è analizzare le catene di approvvigionamento dei medicinali critici indicati dall'EMA e verificare se vi sono eccessive dipendenze da un numero limitato di fornitori esterni, limitate possibilità di diversificazione, limitate capacità di produzione. Questo processo permetterà di individuare gli strumenti più appropriati per intervenire sulle vulnerabilità riscontrate quali: raccomandazioni alle imprese di diversificare i fornitori o aumentare la produzione interna all'UE, incentivi agli investimenti, obblighi normativi in capo alle imprese e appalti che prevedano rigorosi obblighi contrattuali per la consegna.