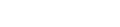ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
05/09/2024 | Press release | Distributed by Public on 05/09/2024 04:43
Egitto: tutti in soccorso del gigante fragile
-
di Aldo Liga
Per oltre due anni il timore che la crisi egiziana potesse sfociare in un vero e proprio tracollo finanziario ha dominato analisi politiche, prospettive economiche e scenari futuri sul Paese. L'invasione russa dell'Ucraina, la fuga di capitali (quasi 20 miliardi di dollari nel giro di poche settimane), gli aumenti esponenziali dei prezzi di grano e petrolio, i continui blackout hanno restituito l'immagine di un'economia vicino al default. A questo quadro sono andati a sovrapporsi l'inizio della guerra civile nel confinante Sudan ad aprile dello scorso anno e, più recentemente, l'attacco di Hamas del 7 ottobre, l'inizio dell'offensiva israeliana su Gaza e la "regionalizzazione" degli scontri con il coinvolgimento di gruppi e milizie da parte del cosiddetto "Asse della Resistenza". Un quadro geopolitico altamente instabile che ha contribuito a fare calare più di un'ombra sul futuro dell'Egitto.
Tuttavia, negli ultimi due mesi, e quasi improvvisamente, questi timori sembrano essersi attenuati. Oggi vediamo un Paese al centro di una nuova ondata di investimenti e pacchetti di salvataggio internazionale: oltre 57 miliardi di dollari fluiranno nelle casse egiziane nel prossimo futuro. Come ha fatto il quadro a cambiare così in fretta? Come si è potuto passare da una temuta catastrofe finanziaria a una rinnovata attrattività da parte dei principali fondi d'investimento della regione e ad una nuova iniezione di fiducia da parte dei principali donatori internazionali?
Tutte le fragilità del "gigante"
Ai primi di aprile, con il giuramento ufficiale di fronte al parlamento, ha avuto inizio il terzo mandato di Abdel Fattah al-Sisi alla presidenza dell'Egitto dopo il trionfo alle elezioni anticipate di dicembre, in cui aveva ottenuto l'89,6% dei suffragi. Le elezioni, inizialmente previste nella primavera 2024, erano state anticipate al fine di poter procedere al più presto all'implementazione di quelle dolorose riforme economiche di cui il Paese aveva urgentemente bisogno.
Con le riserve di valuta estera ai minimi storici, che limitavano fortemente le importazioni anche di beni di prima necessità, un debito pubblico quadruplicato (soprattutto a causa dei mega progetti infrastrutturali portati avanti dal presidente) e la necessità di ripagare nell'anno in corso circa 42 miliardi di dollari di debito estero, agire con celerità sulla ristrutturazione dei fondamenti macroeconomici dello Stato era diventato inderogabile.
A esasperare ancor di più il quadro erano stati il tasso d'inflazione a livelli stellari (33,7% nel mese di dicembre), la lira che aveva perso quasi due terzi del suo valore dall'inizio del 2022, il crollo del volume delle rimesse, l'intensificazione di blackout elettrici a partire dell'estate.
A questo si aggiungevano dati preoccupanti sulla tenuta sociale nazionale, con oltre il 30% della popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà e il rischio di mobilitazioni popolari e proteste, nonostante queste ultime siano vietate in Egitto.
L'attacco di Hamas e la successiva offensiva israeliana a Gaza si sono inseriti in questo contesto già fortemente teso. La guerra di Gaza ha aggravato le condizioni economiche egiziane. Tra i settori in cui le ripercussioni sono state più visibili vi sono il commercio, il transito lungo il canale di Suez, l'energia e il turismo.
Gli attacchi degli Houthi contro le navi commerciali in transito nel Mar Rosso hanno ridotto i volumi di transito lungo il Canale di Suez, uno dei "motori vitali" dell'economia egiziana. Nei primi due mesi del 2024 la crisi del Mar Rosso ha dimezzato i volumi di traffico commerciale nel canale e ha contribuito a una riduzione delle entrate pari al 40-50% rispetto all'anno precedente.
Per quanto riguarda il settore energetico, l'Egitto ha sofferto della forte riduzione del flusso di gas naturale da Israele (il Paese, infatti, importa tale fonte di energia dal vicino sia per soddisfare la domanda domestica sia per le attività di ri-esportazione, che avvengono tramite i terminal GNL di Idku e Damietta). Per oltre un mese e mezzo Israele ha interrotto il flusso dal giacimento di Tamar e questa flessione ha contribuito al crollo delle esportazioni di gas dall'Egitto di quasi il 50% alla fine dello scorso anno. Nonostante oggi le esportazioni israeliane abbiano raggiunto un nuovo record, il deficit di gas è destinato a peggiorare a causa della domanda interna in crescita e del crollo della produzione (pari all'11% rispetto al 2022, anche a causa dei persistenti problemi di infiltrazioni nel giacimento di Zohr). Per questo motivo lo Stato nordafricano ha pianificato di ricorrere al noleggio di una nave galleggiante di stoccaggio e rigassificazione (FSRU): dato il perdurare della crisi nel Mar Rosso, è probabile che il gas naturale verrà importato principalmente da Stati Uniti, Russia e Algeria. Il fatto che le ultime importazioni di GNL risalgano al 2018 rappresenta un'ulteriore dimostrazione dell'importanza della crisi che sta attraversando il settore energetico egiziano.
Anche il settore turistico, che vale circa il 12% del PIL nazionale, è stato fortemente impattato dal clima di incertezza scaturito dal conflitto. Fra ottobre e dicembre del 2023, il numero di visitatori ha raggiunto i 3,6 milioni, circa 600 mila in meno rispetto alle attese iniziali.
Il 2024, fra fragilità strutturali e nuovi fattori di crisi emersi dal conflitto in corso a Gaza e nel Mar Rosso, si era aperto quindi con un Egitto che appariva sull'orlo della bancarotta.
Fragile, ma pur sempre inaggirabile
A causa della persistenza dell'incertezza economica, già nel dicembre del 2022 l'Egitto aveva ottenuto assistenza finanziaria da parte del Fondo monetario internazionale (FMI), con cui aveva sottoscritto un accordo del valore di 3 miliardi di dollari valido per 46 mesi, sotto la Extended Fund Facility. I negoziati per lo sblocco delle prime due tranches si erano però presto impantanati su alcune condizioni stabilite per l'elargizione del prestito, fra cui il passaggio permanente a un tasso di cambio flessibile, l'austerità fiscale e la graduale eliminazione dei sussidi sui prezzi del carburante, nonché la privatizzazione di alcune società pubbliche.
Lo scoppio della guerra di Gaza ha però radicalmente cambiato il contesto in cui l'Egitto si muove, aumentato le leve di cui dispone e rafforzatone il peso negoziale nell'intero quadrante geopolitico mediterraneo e mediorientale. Non solo da un punto di vista diplomatico (dall'organizzazione del Vertice del Cairo per la pace al raggiungimento dell'unico cessate il fuoco temporaneo ottenuto finora, agli sforzi per la liberazione degli ostaggi e la gestione dell'accesso degli aiuti umanitari). In un quadro di crescente instabilità regionale il più popoloso Paese della regione MENA non può e non deve fallire. Perché le conseguenze di una destabilizzazione economica si riverserebbero sull'intera regione. Il collasso economico porterebbe al rischio di contestazioni politiche e rivolte, alla possibile destabilizzazione di un regime considerato cruciale per gli equilibri dell'area da parte di molte delle controparti regionali e internazionali: gli Stati Uniti temono le ripercussioni per la sicurezza di Israele, il Golfo l'incubo di un nuovo 2011 e di una nuova rivoluzione, l'Europa un'ondata incontrollata di migranti.
Se, da un lato, la guerra di Gaza e la sua regionalizzazione hanno quindi avuto un impatto significativo sull'economia del Paese, aggravandone la crisi, dall'altro, paradossalmente, questa ha aperto nuovi spiragli per un suo salvataggio, catalizzando nuovi investimenti, prestiti e forme di partenariato.
Ras El-Hekma e gli investimenti del Golfo
Una dimostrazione evidente di come l'Egitto sia riuscito a sfruttare a proprio favore la congiuntura internazionale sfavorevole è rappresentata dalla mutata attitudine delle monarchie del Golfo nei confronti del Paese.
Oltre al FMI, nell'ultimo decennio sono numerosi gli Stati che hanno sostenuto anche dal punto di vista finanziario il regime di al-Sisi e l'Egitto, in primisArabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.Sono due le ragioni principali: le affinità ideologiche con un regime che ha preso il potere con un colpo di Stato, che ha deposto un presidente eletto appartenente alla Fratellanza musulmana, e le potenzialità di cooperazione economica e militare più stretta. Nel corso del 2023 però le relazioni fra il Cairo e gli Stati del Golfo avevano visto un certo irrigidimento, principalmente dovuto a un cambio di approccio da parte di Riad, Abu Dhabi e Doha. Queste hanno cominciato a rendere chiara la volontà di abbandonare l'incondizionalità con cui avevano concesso fondi e depositi al gigante nordafricano e hanno iniziato a legare qualsiasi forma di assistenza alla realizzazione efficace di un programma di riforme economiche e di governance, cercando quindi un maggiore ritorno dei propri investimenti e una penetrazione economica più pervasiva.
Ma già a fine 2023, dopo l'inizio della guerra, le monarchie del Golfo avrebbero cominciato a mitigare il loro nuovo approccio, riorientandosi verso forme di assistenza, depositi e pacchetti di salvataggio finanziari. È in questo contesto che interviene l'importante svolta dello scorso 23 febbraio. In questa giornata viene infatti annunciato un accordo fra l'Egitto e il fondo sovrano di Abu Dhabi, ADQ, per l'acquisto dei diritti di sviluppo in un'area di 170 chilometri quadrati della costa nord del Paese, Ras El-Hekma, per un totale di 24 miliardi di dollari. Lo scopo è quello di trasformare la penisola in una nuova area urbana, destinazione turistica di lusso e centro finanziario. Viene anche annunciata l'intenzione di investire in progetti di sviluppo con ulteriori 11 miliardi di dollari depositati in precedenza dal fondo presso la banca centrale egiziana.
Questa "chiara forma di assistenza e supporto" da 35 miliardi di dollari rappresenta il più imponente investimento nella storia del Paese, quasi equivalente al valore totale delle riserve di valuta estera detenute dall'Egitto a fine 2023. La prima tranche da 5 miliardi di dollari è stata ricevuta il 29 febbraio, la seconda sempre di 5 miliardi il giorno seguente: 5 miliardi sono stati depositati presso la banca centrale, gli altri 5 sono stati usati per pagare merci importate, bloccate per mesi nei porti egiziani, e per saldare i debiti contratti con i produttori di energia che operano nel Paese.
Il primo versamento ha sbloccato una riforma considerata fondamentale dai principali creditori internazionali dell'Egitto, ovvero la libera fluttuazione del tasso di cambio con il dollaro, annunciata il 6 marzo. Prima del 23 febbraio, infatti, la banca centrale non voleva lasciare al mercato la definizione del valore della lira, non possedendo riserve di valuta estera tali da poter prevenire un crollo della moneta rispetto al dollaro. Con l'investimento di ADQ, invece, il livello di riserve internazionali nelle casse dello Stato nordafricano ha raggiunto il livello più alto dall'inizio della guerra in Ucraina, superando i 40 miliardi di dollari.
L'investimento emiratino non è l'unico proveniente dal Golfo e non è l'unico segno del sopracitato cambiamento di attitudine da parte delle monarchie della regione. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, le autorità egiziane e un fondo d'investimento saudita stanno negoziando la vendita di diritti per lo sviluppo della località di Ras Gamila, a nord di Sharm el-Sheik nella penisola del Sinai, non lontano da Neom, la megacity in costruzione in Arabia Saudita. Anche il Qatar ha recentemente riavviato i negoziati per comprare le quote governative all'interno di società egiziane.
L'ondata di interventi internazionali
All'investimento emiratino hanno fatto seguito nel giro di poche settimane altri interventi internazionali a sostegno dell'economia emergente, che hanno portato il totale di fondi ottenuti a oltre 57,4 miliardi di dollari.
Come già menzionato, la prima tranche dell'investimento emiratino ha sbloccato una delle principali riforme richieste dal FMI, la libera fluttuazione del tasso di cambio. Il 6 marzo, quindi, l'istituto internazionale ha più che raddoppiato l'entità del prestito pattuito a fine 2022, approvandone l'estensione fino a 8 miliardi di dollari. Secondo la direttrice del FMI, l'investimento di ADQ, "se usato con giudizio, aiuterà l'Egitto a tamponare gli shock futuri". Egitto e FMI stanno poi discutendo un ulteriore prestito, altri 1,2 miliardi sotto il Resilience and Sustainability Fund. Pochi giorni dopo l'annuncio di questo prestito, la Banca mondialeha varato un nuovo piano di sostegno del valore di 6 miliardi di dollari, 3 destinati a programmi governativi e a supporto del bilancio dello Stato, e 3 per il settore privato.
L'Europa non è assente da questa nuova ondata di investimenti. Il 17 marzo scorso la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente della Repubblica di Cipro e i primi ministri di Italia, Austria, Belgio e Grecia si sono recati al Cairo per discutere del rafforzamento del partenariato globale e strategico tra Egitto e UE che prevede anche un pacchetto di risorse del valore di 7,4 miliardi: 5 miliardi di prestiti per l'assistenza macroeconomica, 1,8 miliardi di investimenti, 600 milioni di sovvenzioni, compresi 200 milioni per la gestione dei migranti. Evitare che l'Egitto si trasformi in una "rampa di lancio" di nuovi flussi migratori verso le coste europee è considerato essenziale a Bruxelles, soprattutto in un anno elettorale come questo. Su base bilaterale, anche Londra si è mossa, promettendo un aiuto alle finanze egiziane pari a 400 milioni di sterline a supporto del bilancio dello Stato, da erogare nell'arco dei prossimi due anni.
Futuro incerto per un Paese irriformabile?
Quasi 60 miliardi di dollari fluiti all'interno e la prospettiva di nuovi accordi e di partnership bilaterali e multilaterali sempre più forti: sono molti i segnali che, dopo due anni di crisi e un collasso dato per imminente, aprono per l'Egitto nuovi spiragli per una maggiore stabilità economica. Secondo alcuni osservatori, la liquidità ottenuta in questi ultimi mesi dovrebbe garantire stabilità finanziaria al Paese per i prossimi quattro anni. Un ulteriore segno della rinnovata fiducia da parte degli investitori è il successo della domanda di obbligazioni a breve termine emesse dal Tesoro egiziano. Secondo il FMI, entro i prossimi mesi l'Egitto perfezionerà la vendita di state assets per un valore di circa 639 milioni di dollari. L'agenzia di rating Moody's ha recentemente rivalutato il credit outlook sovrano da negativo a positivo.
Gli ultimi avvenimenti dimostrano che quando si dice che l'Egitto è troppo grande per fallire, è vero, ma costituiscono anche un'ulteriore dimostrazione del fatto che il Cairo è in grado, con una certa efficacia, di tenere in "ostaggio" i Paesi circostanti e quelli dell'area euromediterranea. Infatti, il Paese è in grado di mettere sulla bilancia, da un lato, l'irriformabilità di un sistema di potere politico, militare ed economico che innerva qualsiasi prospettiva sul presente e sul futuro e, dall'altro, la salvaguardia della stabilità interna e regionale.
Restano comunque incerte le possibili implicazioni di lungo termine di questo "salvataggio": per quanto tempo il governo manterrà flessibile il tasso di cambio? La maggiore stabilità porterà all'implementazione di riforme macroeconomiche, magari impopolari, o al contrario le posticiperà indefinitamente? Il percorso di stabilizzazione è irreversibile o la crisi è solo rinviata? E quanto sarà più grave fra qualche anno?
Il Cairo si è impegnato a ridurre le spese infrastrutturali e a garantire una maggiore trasparenza nella gestione delle finanze delle imprese di proprietà statale, incluse quelle che vedono una partecipazione dell'esercito. Tuttavia, l'implementazione di queste riforme non è scontata e non è priva di rischi, soprattutto sul piano interno, visto che la presenza dei militari all'interno di società pubbliche e private rappresenta una condizione essenziale della stabilità del regime di al-Sisi. L'Egitto ha poi una comprovata storia di riforme annunciate seguite da passi indietro, ripensamenti e richieste di proroghe. Un altro rischio che non deve essere sottovalutato deriva dal fatto che i 35 miliardi di dollari emiratini possano in qualche modo contribuire a ridurre l'influenza del FMI sul Paese, facendo venir meno la leva dello stop ai fondi in caso di non implementazione delle riforme programmate. Considerando anche l'estrema volatilità geopolitica a livello regionale, sono molte quindi le incertezze che circondano questo inedito flusso di investimenti e di iniezione di fiducia sulla stabilità presente e futura del "gigante dai piedi d'argilla".