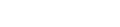ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
05/06/2024 | Press release | Distributed by Public on 05/06/2024 11:07
Polonia: ascesa europeista con riserva
-
di Beda Romano
Dinanzi al palazzo presidenziale di Varsavia, accanto alla statua equestre del generale napoleonico Józef Antoni Poniatowski, sventolano tre bandiere. Oltre al vessillo nazionale e a quello dell'Unione europea (UE), a sorpresa si agita nel vento anche una terza bandiera, quella con sfondo blu dell'Alleanza atlantica.
Fu voluta dal precedente governo, cattolico e conservatore, che nei fatti si riconosceva più nella NATO che nella UE e guardava più spesso a Washington che a Bruxelles. Da allora il cambio della guardia a Varsavia non avrebbe potuto essere più drastico. Dopo otto anni al governo, il partito Giustizia & Diritto (PiS) è tornato all'opposizione. Al potere è giunta Piattaforma Civica, un movimento centrista guidato da Donald Tusk, che è riuscito a formare una coalizione di impronta europeista. A tutta prima, il vessillo della NATO dinanzi a palazzo Koniecpolski può risultare a questo punto incredibilmente anacronistico. Ma quanto anacronistico?
Il ritorno dell'europeista Tusk
La nomina di Donald Tusk alla guida del governo polacco è stata accolta positivamente in molte capitali europee. A 66 anni, l'uomo politico è noto ai più. Non solo perché fu già primo ministro del suo Paese tra il 2007 e il 2014, ma soprattutto perché è stato presidente del Consiglio europeo per cinque anni tra il 2014 e il 2019. Conosce i corridoi di Bruxelles e i meandri della politica comunitaria. Da presidente del Consiglio europeo gestì la crisi migratoria, la tempesta Trump e la minaccia Orbán. È arrivato al potere promettendo di riannodare i legami con l'Unione europea, terribilmente sfilacciati dopo quasi un decennio di potere euroscettico.
Sulla scia delle elezioni di ottobre, Donald Tusk ha ottenuto la fiducia della Sejm (camera bassa del parlamento polacco) in dicembre, con 248 sì e 201 no. Dopo il voto in parlamento, il leader storico del PiS, Jaroslaw Kaczynski, è salito alla tribuna e dal microfono ha urlato rivolgendosi al suo concorrente politico: "Io so una cosa: Lei è un agente tedesco!". Agli occhi dei conservatori polacchi il nuovo primo ministro è un agente straniero, una quinta colonna dell'Unione europea a Varsavia.
Nei suoi primi cento giorni alla guida del Paese, Tusk ha rimesso la Polonia al centro dello scacchiere comunitario. Giunto al potere con la promessa di rivedere molte delle scelte compiute dal governo precedente, il nuovo esecutivo è impegnato a restaurare lo stato di diritto nel Paese. Le misure sovraniste del precedente governo avevano messo drammaticamente in dubbio l'indipendenza della magistratura e la preminenza del diritto comunitario, inducendo l'UE a bloccare i fondi europei destinati a Varsavia. In poche settimane Tusk è riuscito a rassicurare i suoi interlocutori bruxellesi, ottenendo lo scongelamento di 57 miliardi di euro provenienti da NextGenerationEU, il programma finanziario nato dopo la pandemia.
Il nuovo peso polacco nel Triangolo di Weimar
Per anni i rappresentanti polacchi a Bruxelles si erano volutamente isolati. Oggi sono tornati al centro della scena, alla vigilia peraltro di assumere la presidenza dell'UEnel primo semestre dell'anno prossimo, in un contesto internazionale che tra le altre cose potrebbe essere segnato anche dalla rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca.Banalmente è sufficiente assistere all'arrivo del primo ministro in occasione dei Consigli europei: ormai le sue parole alla stampa contano quasi quanto quelle del presidente francese o del cancelliere tedesco.
A questo proposito, con il cambio di governo è tornato in auge il Triangolo di Weimar, il consesso a tre - Germania, Francia e Polonia - nato nel 1991 con l'obiettivo di coltivare i legami tra la coppia franco-tedesca e il principale Paese dell'Europa centro-orientale. Da quando Tusk è arrivato al potere il Triangolo di Weimar si è già incontrato due volte, la prima a livello di ministri degli Esteri, la seconda a livello di capi di Stato e di governo, chiudendo un lungo periodo nel quale l'intesa a tre era praticamente in dormiveglia (non si è registrato alcun incontro tra il 2016 e il 2020). Il vertice del 15 marzo scorso a Berlino tra il cancelliere Olaf Scholz, il presidente Emmanuel Macron e il premier Tusk non ha solo rispolverato un antico consesso. Ha messo in luce il nuovo ruolo della Polonia, in un contesto segnato dalle incomprensioni tra Berlino e Parigi e dall'uscita di scena di Londra.
La partita di Varsavia nei consessi europei
La Polonia non è solo un grande Stato membro dell'Unione europea. È anche un Paese al confine della guerra russa in Ucraina, governato da un uomo politico con una innegabile esperienza europea e internazionale. Tusk gode di particolare rispetto, tanto più ora che tenta di restaurare lo stato di diritto a Varsavia.
C'è di più. I veti o le minacce di veto branditi da alcuni Paesi - dall'Ungheria all'Italia - sono giornalisticamente accattivanti, ma mettono in ombra il fatto che tantissime decisioni a livello comunitario vengono prese a maggioranza, non all'unanimità. In ultima analisi, a nessun Paese conviene isolarsi perché a tutti conviene giocare di sponda e cercare alleati pur di trovare un compromesso e raggiungere obiettivi politici e diplomatici. In questa ottica la Polonia, uscita dall'isolamento in cui era piombata con i governi sovranisti, torna a essere un partner utile, se non indispensabile. Nel Consiglio pesa per l'8,4% della popolazione (rispetto al 13,3% dell'Italia).
Eppure, a dispetto di ciò, la natura del nuovo protagonismo della Polonia andrà valutata caso per caso. Sia nei rapporti con l'Ucraina che sul fronte dell'allargamento il Paese potrebbe assumere posizioni controverse. Per quanto riguarda il primo aspetto, da mesi ormai Varsavia sta rumoreggiando contro le scelte europee di permettere agli agricoltori ucraini di vendere i loro prodotti nel Mercato unico senza pagare dazi. La decisione dell'UE ha provocato un calo dei prezzi, soprattutto nei Paesi frontalieri, mettendo seriamente in difficoltà i produttori locali. La Polonia è segnata da manifestazioni anche violente. Tusk ha addirittura minacciato di non rispettare le scelte di Bruxelles e di reintrodurre dazi unilateralmente. D'altro canto, l'economia ha sofferto nel 2023, crescendo di appena lo 0,2% e pagando lo scotto del conflitto alle porte di casa così come delle perduranti ricadute della pandemia. Nel 2024 la congiuntura dovrebbe approfittare dell'arrivo dei fondi europei, finora congelati.
Anche sul fronte dell'allargamento la posizione polacca rischia di rivelarsi ambivalente. Oggi Varsavia sostiene l'adesione dell'Ucraina e della Moldavia, ma potrebbe diventare un freno quando le trattative entreranno nel vivo. Storicamente gli Stati membri che condividono una frontiera con i Paesi candidati sono quelli più difficili da convincere. L'ingresso della Croazia, tanto per fare un esempio, fu ostacolato per anni dalla Slovenia, preoccupata da nuove forme di concorrenza economica. Si sono appena citate le questioni dell'Ucraina e dell'allargamento, ma si potrebbe anche ricordare che nelle scorse settimane il governo Tusk ha criticato il recente patto migratorio e si è opposto a una armonizzazione fiscale in campo finanziario. In entrambi i casi la sua posizione non è stata molto dissimile da quella dell'esecutivo precedente.
Le divisioni su stato di diritto e rapporti con l'UE
Sul fronte nazionale il desiderio del nuovo governo di restaurare lo stato di diritto non sarà semplice. Alcune istituzioni non sono più indipendenti - la Corte costituzionale, il Consiglio nazionale della magistratura, la Corte suprema. Modificarne lo statuto richiede una maggioranza qualificata in Parlamento così come in ultima istanza la firma del capo dello Stato, Andrzej Duda, un esponente del PiS. Dinanzi alle difficoltà di usare l'iter legislativo, il governo Tusk si appoggia a decreti ministeriali e dichiarazioni parlamentari, flirtando esso stesso con la legittimità costituzionale dei suoi provvedimenti.
Pur valutando positivamente i primi passi del nuovo esecutivo, a Bruxelles numerosi Stati membri si sono interrogati sui modi in cui potrà essere restaurato lo stato di diritto. Ha colpito nel gennaio scorso la vicenda di due parlamentari del PiS, Mariusz Kaminski e Maciej Wasik. Condannati per abuso di potere, hanno trovato rifugio nel palazzo presidenziale, su invito del presidente Duda. Sono stati rocambolescamente arrestati, ma i giuristi si chiedono tuttora se l'arresto non sia avvenuto in violazione di una qualche forma di immunità presidenziale.
Il caso non è banale perché rivela in fin dei conti quanto il Paese sia tuttora profondamente diviso tra liberali e conservatori, tra cattolici e laici, tra città e campagne, tra giovani e anziani. Secondo un recente sondaggio, il 45% dei polacchi valuta positivamente il governo Tusk, mentre il 41% è di avviso contrario. Più in generale a colpire è quanto la Polonia continui a rimanere fredda nei confronti dell'Europa, a 20 anni dall'adesione. Un recente studio demoscopico di More in Common rivela che il 41% della popolazione si oppone al processo di integrazione europea. Alla domanda sulle prospettive della Polonia fuori dall'UE, solo il 57% degli interpellati si dice preoccupato da una tale evenienza.
In fondo, nel valutare il nuovo protagonismo della Polonia sulla scena europea si dovrebbe tenere a mente che la battaglia politica di questi anni fa parte, in fondo, del processo di apprendimento di un Paese alle prese tuttora con un corso accelerato in democrazia liberale. La Polonia sparì dalle cartine geografiche tra il 1791 e il 1918, diviso tra gli imperi del momento, ovvero la Germania, l'Austria e la Russia. Mentre nell'Ottocento altrove in Europa il moderno Stato nazionale prendeva lentamente forma, la Polonia era in balia dei suoi vicini. Il Paese ritrovò l'indipendenza alla fine della Grande Guerra, in modo non dissimile peraltro dalle colonie europee in Sudamerica o in Asia. Solo dal 1989 è tornata ad assaporare finalmente la libertà, ma incredibilmente continua a vivere con ambivalenza la costruzione comunitaria. È consapevole dei vantaggi e dei meriti, ma ne teme le costrizioni e i laccioli.
Paradossalmente molti polacchi preferiscono il legame con l'Alleanza atlantica a quello con l'Unione europea, come lascia intendere la bandiera della NATO sventolante davanti al palazzo presidenziale. Al netto delle diverse sensibilità politiche dei governi che si susseguono a Varsavia, la Polonia continua a fare i conti con le vicissitudini della sua Storia.