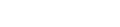CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
05/13/2024 | News release | Distributed by Public on 05/13/2024 02:36
#podcast Agrifuturo, n. 8: estremi di temperatura e i loro impatti sulle colture
NEWS
remove
13 MAY 2024
#podcast Agrifuturo, n. 8: estremi di temperatura e i loro impatti sulle colture
Agrifuturo: il Clima cambia, l'agricoltura risponde. L'ormai familiare sigla del #podcast promosso dal Progetto Life ADA - ADaptation in Agriculture - a cui il CREA ha aderito con il Centro di ricerca Politiche e bioeconomia per supportare concretamente il settore agricolo e rafforzare le sue capacità di resilienza ai cambiamenti climatici - ci introduce all'Episodio 8 - Estremi di temperatura.
Condividi
share
Partendo da un'analisi delle temperature degli ultimi anni, prodotta da Copernicus Climate Change Service, uno dei servizi forniti dal programma di osservazione della terra Copernicus dell'UE, il narratore riferisce che l'estate 2023 ha battuto i record di temperatura, a livello globale, e che queste temperature si mantengono record anche per la stagione autunnale, mettendo il 2023 sulla buona strada per diventare l'anno più caldo di sempre.
È intuitivo pensare che l'aumento nella frequenza degli eventi di siccità possa andare di pari passo con l'aumento della frequenza delle ondate di calore, cioè di temperature massime molto alte; meno intuitivo risulta pensare che il riscaldamento globale possa portare anche a un aumento delle gelate tardive alle nostre latitudini.
In questa puntata si analizzano i due aspetti apparentemente opposti.
Si parte con la definizione di ondate di calore: secondo il Ministero della Sanità, sono condizioni meteorologiche estreme, che si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associati a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni ostacolano la dissipazione dell'energia e rappresentano un rischio per la salute della popolazione.
In riferimento al loro effetto sulle piante, si specifica che, in condizioni non estreme, cioè fino a una certa soglia termica, il tasso di fotosintesi delle piante cresce all'aumentare delle temperature; questa soglia varia da pianta a pianta: per esempio è più alta per il mais, più bassa per il frumento. Oltre tale soglia, si verifica una progressiva diminuzione dell'efficienza produttiva, con rallentamento dello sviluppo e della crescita delle colture, anche in presenza di normali dotazioni idriche.
Ascoltando il podcast, si apprende che, quando alle elevate temperature si associano alti livelli di radiazione solare - eventi che si verificano in condizioni di alta trasparenza atmosferica e, quindi, con bassi valori di umidità relativa - si possono avere danni sulla superficie dei vegetali: questo è un fenomeno che gli agricoltori stanno conoscendo negli ultimi anni e prende il nome di "sunburn", o scottature solari, ovvero danni sui frutti, bacche e foglie di una pianta, causati principalmente da esposizione diretta alla radiazione solare. Per essere più precisi, le scottature sono il risultato della combinazione di elevate intensità luminose, radiazioni ed elevate temperature.
In generale, i danni che si osservano sui frutti possono essere limitati a imbrunimenti sulla buccia, senza danni alle cellule sottostanti, oppure possono essere più gravi, con decolorazione e necrosi sia all'epidermide che alla polpa. Il risultato è una perdita in resa oppure un mancato raggiungimento di standard di maturità tecnologica, che rende i frutti inadatti alla commercializzazione.
Viene fornita una indicazione quantitativa: le temperature sui frutti che determinano le scottature vanno dai 31° a oltre i 40° gradi centigradi, valori facilmente raggiungibili in estate, soprattutto durante l'invaiatura - cioè, la fase della maturazione corrispondente alla colorazione dei frutti.
Come sarà l'evoluzione di questi fenomeni? Lo speaker ne parla con l'agronomo Giampiero Reggitori, che spiega quali sono le migliori soluzioni di adattamento che gli agricoltori possono applicare.
Per esempio, sulla cultura della vite l'irrigazione ha molteplici effetti: l'effetto climatizzate della traspirazione in una pianta con una buona dotazione idrica dissipa il calore sugli acini ed evita l'avvizzimento. Inoltre, l'irrigazione evita la caduta delle foglie basali che proteggono le bacche dalla radiazione solare.
In viticoltura, questo tipo di azione di adattamento deve essere ben calibrato e applicato con buon senso poiché alcuni parametri qualitativi possono essere influenzati negativamente. Ad esempio, è stato osservato che l'irrigazione a ridosso dell'invaiatura ha un effetto negativo sull'accumulo degli antociani e quindi sulla colorazione delle uve; inoltre, l'applicazione di interventi irrigui dovrà essere effettuata e regolata in relazione al disciplinare di produzione di un determinato tipo di vino.
Nella seconda parte della puntata, si fanno i conti anche con le temperature minime estreme: cioè, con le gelate tardive - quelle che si verificano dopo la fine dell'inverno, all'inizio della primavera o a primavera inoltrata - i cosiddetti "ritorni di freddo".
Anche in questo caso la voce narrante mette in fila le gelate tardive storiche che hanno colpito l'Emilia-Romagna, regione pilota del Progetto: il 1997 - anno in cui tutte le produzioni frutticole presenti in regione, compresa la vite, sono state più o meno pesantemente condizionate; il 1998, in cui l'actinidia ha subìto perdite consistenti; il 2000, con danni più limitati, ma presenti in diversi comprensori vocati della frutticoltura regionale. Se guardiamo al 2003, l'intensità del gelo si è manifestata, anche tardivamente, in gran parte del nord e del centro Italia; negli anni più recenti eventi significativi si sono verificati nella primavera del 2017 e poi nel 2020, 2021, e l'ultima gelata è della primavera 2023.
Ma perché si verificano e si sta registrando in aumento nella loro frequenza? Gli inverni miti conseguenti al riscaldamento globale portano a un risveglio vegetativo anticipato, con fasi fenologiche più avanzate e maggiormente sensibili ai ritorni di freddo primaverili. In questa stagione, una diminuzione della temperatura al di sotto dello zero può provocare, negli organi riproduttivi delle piante, il congelamento dell'acqua all'interno delle cellule o negli spazi intracellulari, producendo rotture delle membrane e disidratazione dei tessuti. A seconda della fase fenologica della pianta colpita da gelata tardiva, si possono avere danni più o meno gravi: da modifiche del colore dei tessuti, a malformazioni, necrosi degli organi colpiti: tronchi, foglie, gemme, fiori e frutticini.
L'ammontare dei danni dipende, quindi, dalla sensibilità propria della specie e della cultivar al momento della gelata, che è funzione della fase di sviluppo, e dal tempo durante il quale la temperatura rimane al di sotto della temperatura critica. In genere le gelate tardive primaverili sono dovute a un raffreddamento di tipo "radiativo", raffreddamento che è causato dalla perdita notturna di calore del suolo per irraggiamento da parte del terreno e delle piante stesse, in condizioni di bassa umidità relativa e calma di vento a livello locale. In queste condizioni l'atmosfera si stratifica, l'aria più fredda si concentra vicino al suolo e può subire anche piccoli movimenti legati alla topografia. Per questo, di notte spesso si riscontrano differenze di diversi gradi anche a distanze di poche decine di metri. Questa tipologia di gelata è, quindi, difficile da descrivere per l'elevata variabilità spaziale e temporale della temperatura, visto che le condizioni favorevoli si possono verificare a livello locale.
Come di consueto, il #podcast dà anche la buona notizia, cioè abbiamo a disposizione tecniche di difesa per contrastare, almeno entro certi limiti, il raffreddamento di tipo radiativo e quindi contenere i danni.
L'altro tipo di gelata descritta è di tipo "avvettivo", causata da incursioni di masse estese di aria fredda di origine polare o artica. Queste gelate, quando l'aria è molto fredda, sono senz'altro le più devastanti, ma fortunatamente si verificano di solito in inverno quando le piante sono dormienti e quindi poco sensibili. Soltanto in alcuni sporadici casi - le gelate memorabili del 1929, del 1956, del 1985 - esse hanno provocato ingenti danni.
#Agrifuturo ricorda che, in diversi casi, le due tipologie di dati si sono manifestate insieme, dando origine a quella che chiamiamo "gelata mista", diventata più frequente negli ultimi tempi. Facendo un'analisi delle temperature tra la fine di marzo e il mese di aprile, osserva come nel clima recente - 1991-2020 - l'ultima decade di marzo sia caratterizzata da un notevole aumento della presenza di valori delle minime, prima dell'alba o anche durante la notte, inferiori allo zero e come - sempre negli anni più recenti - nella prima decade di aprile si siano verificati i casi in cui la media della temperatura minima giornaliera della pianura risulta inferiore allo zero, cosa mai accaduta nel clima passato, 1961-1990.
Anche qui, però, c'è un messaggio positivo: negli anni sono state sviluppate numerose e diverse tecniche di difesa contro le gelate tardive, per ridurre i danni rispetto a ciò che si osserverebbe senza alcun intervento mirato. Un aiuto prezioso per gli agricoltori in questa fase climatica.
Ascolta l'ottava puntata del #podcast AgriFuturo
https://www.spreaker.com/.../estremi-di-temperatura...
https://open.spotify.com/episode/6KDzM6UniFYzv6OwcFJvAQ
https://podcasts.apple.com/.../estremi-di.../id1674634912...
Per informazioni contattare:
Condividi
share