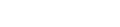ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
05/06/2024 | Press release | Distributed by Public on 05/06/2024 11:07
Unione europea: addio alle ambizioni del Green Deal
Si è ormai prossimi allo scoccare dell'ora in cui gli europei saranno chiamati nuovamente a votare per definire il prossimo Parlamento. Un passaggio che influenzerà la composizione della prossima Commissione. Da più parti, si parla già di voto storico per il futuro dell'Europa unita e delle istituzioni comunitarie, incapaci di far fronte alle sfide odierne: una competizione geopolitica crescente, uno svantaggio latente con altre economie e un rallentamento nell'innovazione tecnologica rispetto ai competitor globali. Secondo altre visioni, invece, se la natura dell'UE è destinata a cambiare, ciò è già stato deciso anzitempo da fenomeni internazionali, non per ultimo il conflitto tra Russia e Ucraina. In questo caso, nessuno scossone è previsto abbattersi su Bruxelles e le altre capitali.
A prescindere dall'esito del voto, la prossima Commissione sarà in ogni caso quella che completerà il decennio considerato chiave per la lotta ai cambiamenti climatici. Inevitabilmente, essa dovrà assumersi oneri e onori della strategia chiave implementata per affrontare tutto ciò, il Green Deal.
Riscoprire le origini
Lo European Green Deal incarna, forse più di ogni altra strategia, lo spirito politico che ha animato la Commissione europea vicina alla propria scadenza di mandato. Il Green Deal viene presentato nel dicembre 2019 dall'allora neoeletta presidente della Commissione Ursula von der Leyen come la "nostra visione per un continente neutrale a livello climatico." Una "roadmap per l'azione" concreta e indirizzata al raggiungimento degli obiettivi al 2050, sfruttando "le opportunità significative, come la potenziale crescita economica, lo sviluppo tecnologico e del business" celate dietro la transizione.
Decine, anzi, centinaia di miliardi di investimenti tra pubblico e privato sono stati promessi a sostegno di questa serie di misure con l'intento di cambiare il volto dell'Europa nel breve ma soprattutto nel lungo periodo. Un piano strategico che, accompagnato da una serie di interventi di diplomazia climatica come il Just Transition Mechanism e il Global Gateway, e successivamente di politica industriale, come il Net-Zero Industry Act e il Critical Raw Materials Act (parte del Green Deal Industrial Plan), è stato animato dall'intento di fornire un "modello di comportamento" che altri giganti come India e Cina avrebbero dovuto seguire.
Tutte le tonalità del Green Deal
Una volta introdotto, il Green Deal ha reso l'Europa il primo continente con un'agenda climatica per la neutralità carbonica entro il 2050. Un'iniziativa che, marcatamente, è stata voluta per incrementare la coesione interna all'UE, ma che ha dato anche il via a un'importante corsa delle principali potenze a legittimarsi come campioni dell'eranet-zero.
Se l'UE ha infatti annunciato un taglio delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 (comparate al 1990), pochi mesi dopo anche la Cina ha presentato alle Nazioni Unite una strategia dual-carbon goal con un picco di emissioni al 2030 e il raggiungimento di una neutralità carbonica al 2060. Gli Stati Uniti, nel primo giorno della Presidenza Biden, sono invece rientrati nell'Accordo di Parigi dopo la fuoriuscita durante l'Amministrazione Trump. Due eventi, questi, di eccezionale importanza e che certamente sono stati influenzati grazie anche all'intraprendenza europea.
Ma, oltre a un'agenda per creare un sistema economico, industriale e finanziario che fa pace con sé stesso, mettendo l'azione climatica per invertire gli effetti di un devastante e incontrollato antropocene al centro del policy-making europeo, il Green Deal è molto più di una sommatoria di azioni. Per vincere questa sfida, rappresentata dalla generazione di un innovativo processo co-evolutivo di politiche, tecnologie, valori culturali e istituzioni economiche, è stata considerata imprescindibile la realizzazione di un patto condiviso innanzitutto tra ventisette diversi Stati membri.
In un quadro già frammentato di politiche energetiche nazionali, le condizioni economico-sociali che attraversano obliquamente le società europee sono infatti apparse da subito determinanti per ottenere un supporto sufficiente. In loro assenza, il Green Deal rischierebbe di essere recepito come un'imposizione dirigistica, calata dall'alto. Solidarietà, sviluppo sostenibile e protezione dell'ambiente sono infatti concetti che devono ancorare fermamente l'intero processo di transizione. Il loro contributo è indirizzato soprattutto a formare un framework legale e regolatorio che faccia da cornice alla concretizzazione della strategia.
Aspetti che dal concettuale danno modo alle ambizioni climatiche e ambientali di permeare l'intero ordine legale, ma anche la finanza pubblica e privata. Nozioni che, pragmaticamente, incidono su tutti gli aspetti che accomunano qualsivoglia studio sugli scenari per una transizione veloce e meno dolorosa possibile: l'elettrificazione dei consumi e la fuoriuscita delle tecnologie fossili (incluso il gas naturale), la decarbonizzazione dei settori industriali cosiddetti hard-to-abate, l'efficientamento dei consumi domestici e, infine, un'inversione del trend in crescita delle emissioni dal settore dei trasporti.
Le prove sotto sforzo della strategia
Che la Commissione von der Leyen avesse di fronte una strada in salita era parsa, francamente, una certezza sin da subito. Nessuno però poteva immaginare che nel giro di ventiquattro mesi l'UE andasse incontro prima alla principale pandemia globale dell'era contemporanea. Né che successivamente la guerra combattuta sul campo emergesse come un elemento cronico all'interno dell'Europa stessa e nelle sue più prossime periferie.
Nel pieno di un'emergenza come quella di Covid-19, è apparso subito chiaro che le ambizioni del Green Dealdovessero passare in secondo piano. Non per questo, il periodo immediatamente successivo ai lockdowns, caratterizzato da una largesse economica senza precedenti nella spesa pubblica, ha incapsulato molte delle possibilità di mutare la traiettoria di lungo periodo dell'intensità carbonica delle economie europee.
Se la crescita successiva alla crisi pandemica ha infiammato la spesa pubblica, inclusa quella per investimenti nel settore delle fonti rinnovabili, i consumi energetici globali hanno però strabordato oltre gli argini costituiti all'interno dei sistemi energetici europei. Una marea improvvisa, la quale ha prosciugato l'offerta eccedente sui mercati e ha preparato il terreno per la nuova prova di forza, l'invasione russa dell'Ucraina e il fallimento dei mercati energetici europei di contenere i rialzi di prezzo. Così, mentre i tabù energetici vigenti cadevano uno dopo l'altro, fette crescenti della popolazione europea hanno imparato sulla loro pelle il significato di povertà energetica.
La crisi si è così trasformata o, anzi, è transitata velocemente dall'essere prettamente energetica a divenire una crisi politica e di legittimità delle istituzioni europee. Nonostante un'inflazione in calo, l'incapacità di affrontare un tema come quello monetario, con tassi di interesse ancora fuori scala, hanno portato a galla una tensione crescente sulle strategie da adottare all'interno della stessa Banca centrale europea. Se da una parte le fonti rinnovabili sono state benedette dal Green Deal, la situazione monetaria e finanziaria non ha fatto altro che dissestare il panorama evolutivo dei due settori chiave della strategia europea, eolico e solare.
Crisi politica e di legittimità
Giunti alla metà del decennio chiave per la transizione europea, il Green Deal vive il suo momento di maggior difficoltà e di messa in discussione. La protesta degli agricoltori, largamente vittoriosa in pressoché ogni Paese europeo, ha reso palese il livello di politicizzazione dello scontro riguardante il futuro del Green Deal e delle misure atte ad accelerare la transizione. Ogni muro eretto a difesa del cuore della Commissione von der Leyen pare cadere, quand'anche la presidente del Parlamento europeo, la maltese Roberta Metsola, invita i policymakers europei a "monitorare da vicino gli effetti nella vita reale delle nostre decisioni." Un invito al pragmatismo, ma che evidentemente fatica a conciliarsi con l'aumento delle emissioni riscontrato a livello globale e uno scarto sempre più evidente tra i ritmi di crescita dell'economia europea e quelli nel resto del G20.
Nel frattempo, lo scenario in cui si muove il Green Deal è mutato drasticamente e, con esso, la sua stessa natura. Dal costituire il bigliettino da visita delle ambizioni globali UE, quell'humus politico e culturale alimentato dai concetti di sostenibilità, sviluppo sostenibile e protezione dell'ambiente oggi rischia di far germogliare nel cuore dell'Europa l'ennesimo seme di corsa al protezionismo e alla frammentazione delle supply chains. Il tutto senza alcuna assicurazione che l'industria verde europea sia in grado di consolidare il proprio terreno.
Ora che le radici del Green Deal paiono essere assai meno sedimentate di quanto si credesse, la politica si adegua all'onda montante. Anche il Partito popolare europeo mette in cattiva luce le scelte di von der Leyen e pretende un cambio di passo. Preparandosi alla tornata elettorale imminente, ci si attende una svolta a destra che minaccia, nella risacca, di far affondare anche le ultime aspirazioni di un futuro net-zero in Europa.